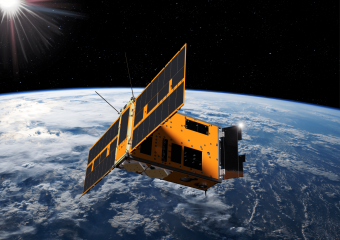Dall’Universitas alla Noosfera
Come educare alla salvezza del Pianeta
(Chi è responsabile di ciò che sta accadendo al nostro Pianeta?
Riflessioni sulla Missione dell’Università nel 21esimo Secolo)
Dott. Alexander Kovriga
(Università Nazionale “V. Karazin”, Ucraina)
Conferenza Pubblica Internazionale presso
Università di Rhode Island, 27 Aprile 2011
Buon pomeriggio a tutti!
Sono molto onorato di essere qui e apprezzo tutti gli sforzi fatti per rendere possibile questo evento.
Voglio ringraziare in particolar modo il Rettorato, il Decano di Arti e Scienze, l’URI Honors Program e il dipartimento di Scienze Politiche per la cortese assistenza nella preparazione di questo incontro presso il vostro bel campus.
Capisco che le previsioni e speculazioni sul futuro costituiscano attività intellettualmente deprecabili. E che nel cercare di parlare del futuro dell’università, nel Paese che ne ospita tante (buone e all’avanguardia) quante il resto del mondo messo assieme, il rischio per me è molto alto.
Ma mi preoccupa che, in un mondo sempre più complesso ed interconnesso, coloro che possono alleviare le nostre paure su ciò che ci riserva il futuro, siano come l’orbo nel regno dei ciechi. Non vedranno molto bene, ma sapranno vedere come fare profitto.
Direi che questi costituiscono, di fatto, tentativi di privatizzazione del futuro, di sfruttamento per tornaconto personale. Qualcuno potrebbe chiamarlo “saccheggio del futuro”. Nelle scienze sociali la manipolazione della nostra percezione del futuro serve finanche come strategia – un tentativo di prevedere ed assicurare la vittoria di specifiche visioni del mondo.
Spero di convincervi oggi che uno scopo basilare dell’università dovrebbe essere quello di contrastare simili tentativi di privatizzazione del futuro.
Apprezzo molto il motto della vostra università: Pensa in Grande – Noi lo Facciamo.
Nello spirito di questo motto vi dico che, soprattutto oggi che ogni problema regionale ha implicazioni globali, il pensiero aperto e critico sulla natura e lo scopo dell’università è assolutamente essenziale.
L’Università, come istituzione cardine della civiltà, è sopravvissuta per molto secoli. Ma adesso l’intera struttura dell’educazione superiore, le modalità di trasferimento della cultura, i nostri schemi di pensiero, riflessione e creatività stanno mutando rapidamente.
E’ nostra responsabilità parlare ed agire in difesa del ruolo dell’Università nella società, e riorientarla per fronteggiare le sfide attuali e contribuire alla salvezza e allo sviluppo dell’intero genere umano.
Perché questo tema è così importante adesso? Perché il mondo intero è in una fase di transizione e il Futuro del Pianeta dipende dall’azione delle comunità universitarie e dal loro sviluppo.
Le università sono sempre state incubatrici naturali del futuro, centri per la creazione di nuove conoscenze e abilità, e per la disseminazione di nuove visioni del mondo.
Le catastrofi causate dall’uomo agli inizi del 21esimo secolo ci mostrano che i vecchi paradigmi sull’andamento del globo non sono solo irrimediabilmente superati, ma possono condurci ad una catastrofe(1).
Perché il genere umano si ritrova continuamente coinvolto in situazioni inaspettate con l’affacciarsi continuo di nuove minacce nucleari, demografiche, finanziarie, politiche, legate allo sviluppo, etc.?
A seguito di ogni nuova crisi, vengono fatti enormi sforzi per neutralizzare simili minacce, ma ciò non garantisce che le successive verranno affrontate con successo. Chernobyl; uragano Katrina; crisi finanziaria globale; fuoriuscita di petrolio nel Golfo; Fukushima: perché tutto procede in questo modo?
Perché il Genere Umano non è libero come dovrebbe nel definire il proprio percorso di sviluppo.
Molti degli strumenti tradizionali che incoraggiavano l’autoriflessione ed una ponderata ricerca per uno sviluppo futuro sensato sono stati distrutti, o sono semplicemente “passati di moda”.
Abbiamo limitato la nostra stessa libertà di scelta permettendo a noi stessi di diventare schiavi di stereotipi e di ingenue ideologie, la più grande delle quali è la supremazia del mercato.
Come risultato, la comunità globale è ovunque incapace di comprendere il suo potenziale. Non si assume la responsabilità delle proprie azioni.
Non ammette la propria responsabilità sull’ambiente.
Ir-responsabilità e assenza di obiettività hanno infettato a tutti i livelli le istituzioni, gli stati, le imprese e, ovviamente, i media, e questa è diventata la ragione principale per la quale restiamo sempre indietro nel rispondere a nuove minacce causate dall’uomo che, scientificamente parlando, sono interamente prevedibili.
Sappiamo, è un’inevitabilità statistica, che le centrali nucleari sono soggette a incidenti, ma nessuno di fatto ne risulta responsabile quando ciò accade. Sappiamo che le epidemie devasteranno il pianeta, ma non è predisposto alcun meccanismo di prevenzione al riguardo. Sappiamo che i mercati crollano periodicamente, ma quando collassano tutti paiono sorpresi e nessuno sa cosa fare.
Ovviamente, ognuno è chiamato in causa per la sopravvivenza del pianeta, e tuttavia non esiste ancora un corso di laurea chiamato “Assunzione di rischio e responsabilità per la sopravvivenza del Pianeta”.
Lo sviluppo di una simile disciplina nelle nostre università necessita apparentemente di una rappresentazione molto più complessa dei cicli di lungo termine delle società [e civiltà] rispetto a quelle che siamo al momento capaci di produrre.
Il Genere Umano può ora restare intrappolato in forze così complesse e potenti da superare le proprie capacità di controllo sulle stesse. Restando prive di controllo, queste ci minacciano con l’estinzione. La teoria della selezione naturale, che è stata così influente nel formare la nostra visione del mondo in settori che spaziano dall’economia alle relazioni internazionali, è divenuta essa stessa fonte di pericolo per la specie.
Nel mondo mediatico attuale è certamente facile limitarsi a disseminare informazioni, ma cambiamenti basilari nelle visioni del mondo, la creazione di nuove categorie del sapere, la riproduzione e la preparazione delle nuove generazioni nel mettere a frutto tale conoscenza, dipendono ancora dall’Università.
Così si pongono davvero le basi per la sopravvivenza del Genere Umano.
Ho trovato un unico aspetto positivo in questa crisi.
La prima volta è stata quando il paese nel quale vivevo – l’URSS – si è dissolto, e molti nuovi paesi – Ucraina inclusa – sorsero al suo posto. Come effetto immediato di questi eventi, ho avuto la possibilità di viaggiare per l’Europa e gli Stati Uniti e partecipare ad un certo numero di programmi di alto livello di pianificazione strategica e di management. Infine, lavorando come consigliere per l’istruzione con il precedente presidente d’Ucraina, mi venne affidato il compito di tentare di elaborare un nuovo sistema nazionale di istruzione.
Sono sempre stato uno studente brillante, fino a che non ho cominciato a pormi delle domande. Ho studiato architettura e pianificazione urbana, credendo ingenuamente che gli architetti avessero le capacità sufficienti a creare nuove città e, con esse, una migliore qualità della vita.
Insoddisfatto, al termine di quattro anni di studio, mi recai a Mosca per un incontro con i più grandi professionisti della pianificazione urbana. Qui, presso l’Istituto Centrale di Scienza e Design per Pianificazione Urbana, ho collaborato alla progettazione di una nuova Tractor City per 500.000 persone. Questo esercizio futile mi ha insegnato che è impossibile prevedere con la minima certezza scientifica tutte le ramificazioni delle grandi scelte strategiche e di investimento che ci veniva chiesto di effettuare. Ciò mi ha portato a ripensare totalmente il mio approccio e a considerare se come specie possiamo davvero essere capaci di affrontare il nostro futuro affidandoci esclusivamente alla conoscenza quantitativa e all’esperienza tecnica.
Agli inizi degli anni ’80, presi parte ad un gruppo radicale di intellettuali alla ricerca di nuovi modelli di politica sociale. Per tutto il decennio abbiamo tenuto più di 100 incontri di durata settimanale affrontando complesse problematiche nei maggiori centri intellettuali del Paese.
La perestroika doveva giungere dopo diversi anni, ma le nostre ambizioni erano già molto più grandi. Ci siamo posti come obiettivo la preparazione di un nuovo tipo di specialista – qualcuno in grado di portare nuove tecnologie e progressi socio-economici.
27 anni fa ciò era chiamato, in gergo burocratico, “Programma per l’Intensificazione di Attività Innovative e l’Accelerazione del Progresso Scientifico e Tecnico” (2).
Oggi, in America, credo venga chiamato “conquistare il futuro” [шутка].
Allora, il Ministro dell’Istruzione dell’URSS scelse 4 università – Mosca, Minsk, Riga e Kharkov – per preparare specialisti nella sfida verso la trasformazione del Paese. Dopo aver completato il mio dottorato nel 1985, fui mandato a Kharkov per dirigere il progetto.
Avevamo carta bianca per costruire un sistema (non sovietico) di formazione manageriale partendo dal nulla. Abbiamo eliminato le discipline tradizionali e pensato invece esclusivamente tramite case-studies e simulazioni di crisi reali. La tesi di laurea prevedeva proposte di risoluzione per simili crisi.
Sebbene ricevessimo ottimi riscontri dal Ministero dell’Istruzione, non appena le riforme neo-liberali si affermarono nel mio Paese, tutti i fondi per progetti sperimentali cessarono e la maggior parte dei nostri laureati emigrò da Mosca verso l’Occidente.
Questa esperienza mi ha insegnato che, affinché le innovazioni nel campo dell’istruzione abbiano successo, devono includere una sfera di applicazione pratica. E, per riuscire in simile sperimentazione, è necessario ricevere incoraggiamento e supporto di lungo termine.
Successivamente sono stato nominato responsabile del Dipartimento di Scienze e Istruzione per il Presidente d’Ucraina, appena dopo la “Rivoluzione Arancione” del 2004.
Avevo proposto iniziative tese a rafforzare il ruolo della cultura e delle discipline umanistiche ad ogni livello curriculare, per creare ciò che ho chiamato “Una Nazione di Apprendimento”. Ho incontrato un discreto successo, ma questo venne frustrato dal fatto che ogni iniziativa veniva adesso valutata anzitutto con il criterio del profitto.
Costruire una politica di istruzione sovrana, autenticamente nazionale, è oggi pressoché impossibile per un paese povero. Durante il mio incarico presso la Presidenza, gli attori principali del sistema di istruzione ucraino erano la Banca Mondiale e l’Open Society Institute di George Soros. Ciascuno aveva la propria agenda e l’identità ucraina, nonché il ruolo che l’università poteva giocare nella costruzione della stessa, non erano ivi contemplati.
Ho avuto una bella lezione sull’interdipendenza dei mercati globali durante i miei tre anni nell’amministrazione presidenziale.
Ma senza una visione di strategie di lungo termine e di obiettivi specifici per l’Ucraina, qual è il senso della politica nazionale? Qual è il senso dello stesso esistere di una nazione?
Ed arriviamo così allo scopo dell’Università.
A seguito del collasso economico globale, si è diffuso il luogo comune per il quale staremmo vivendo una profonda crisi. A mio parere, in verità, l’ultima crisi finanziaria è nient’altro che conseguenza di una crisi della civiltà occidentale che sta andando avanti da lungo tempo.
Tale crisi di lungo termine richiede una nuova concezione dell’università e della formazione universitaria che ci conduca oltre i limiti del progetto illuminista di modernità, il quale ha promosso un unico modello di sviluppo umano, e che ha avuto luogo nella propaggine nord-occidentale dell’Eurasia, a scapito di ogni altra storia ed esperienza umana.
Il superamento della crisi interna alla civiltà occidentale è dunque inestricabilmente legato al trascendimento della “fine della storia” (cit.) e dello “scontro di civiltà” (cit.), sostituendo quest’ultimo con una meno netta concezione della storia e della civiltà globale ed anche del nostro ruolo, più modesto, nelle stesse. Ciò richiederà una modalità qualitativamente nuova di apprendimento, che ambisca a preservare, più che alterare, i valori fondamentali delle civiltà diverse dalla nostra.
Il mio stesso punto di partenza è nell’opera del grande accademico russo-ucraino Vladimir Vernadsky, il quale è noto in Occidente soprattutto per aver introdotto il termine “biosfera”. Secondo Vernadsky, la consapevolezza umana dell’interconnessione della geosfera, e quindi della biosfera, potrebbero finalmente condurre il genere umano ad una consapevolezza dell’interconnessione dell’intero patrimonio cognitivo umano, al quale lui si riferiva con il termine noosfera.
Se pensiamo allo sviluppo del nostro pianeta come a quello di un singolo organismo, come Vernadsky ci incoraggia a fare, le Università assumono non solo la funzione di cervello, ma anche di sistema circolatorio per l’organismo. Esse sviluppano il sapere fondamentale che deve essere distribuito attraverso specifiche organizzazioni sociali e commerciali.
Nel mondo attuale le Università sono le sole organizzazioni a godere di sufficiente autonomia dalle istituzioni politiche ed economiche dominanti e ciò permette loro di considerare nuovi modelli di organizzazione industriale e socio-culturale, nuovi sistemi di produzione e tipologie istituzionali, e nuove modalità di impiego nella prospettiva dell’interesse di lungo termine della razza umana, più che non di quello del bilancio trimestrale o della prossima tornata elettorale.
Vernadsky ha anticipato che la Noosfera potrebbe infine emergere come una forza creatrice capace di agire su scala planetaria. Al riguardo potete seguirne lo sviluppo sul sito web del “Progetto di Coscienza Globale” curato dal professore Roger Nelson da Princeton. [http://noosphere.princeton.edu/]
Implicitamente, tuttavia, si è dibattuto a lungo, in una scuola di filosofia russa conosciuta come cosmismo, che se il genere umano è forza creatrice dell’universo, allora ciò avrà sicuramente implicazioni anche al di là del nostro pianeta.
Essi ritengono che, affinché la specie umana sopravviva, deve estendere le sue forze creatrici per tutto il sistema solare e oltre, ottenendo così l’equivalente funzionale dell’immortalità (3).
O, come diceva in maniera più poetica il filosofo russo Evald Ilienkov: “Lo scopo dell’Umanità è accendere un altro Sole nell’Universo”.
Per impedire la morte del pianeta terra, l’umanità deve abbracciare il suo potenziale di attore cosmico ed aspirare a tutti i nuovi tipi di sapere che ciò richiederà.
Tuttavia, la sfida più immediata è formulare sapere in modalità che ci permettano di comprendere l’interdipendenza del nostro pianeta concepito come un tutt’uno, ed il co-sviluppo di tutte le specie che ci vivono. Questa è la fondamentale precondizione per l’affermarsi della noosfera.
Come sarebbe una simile educazione all’Umanità Cosmica?
Anzitutto, dovrebbe essere in grado di tramandare alle future generazioni il corpus di idee, conoscenze e rappresentazioni che fungono da base per il nostro benessere materiale e spirituale.
Dopodiché, dev’essere designato all’espansione della capacità umana di auto-trasformazione – individuale, sociale, istituzionale e tecnologica. Una formazione crea “capitale umano” solo se supera i modelli esistenti di attività e produzione, senza limitarsi a riprodurre “ciò che funziona”.
Inoltre, essendo una delle grandi istituzioni permanenti dell’umanità, l’università non deve mai dimenticare che la sua vera vocazione è focalizzarsi sulle questioni ultime dell’esistenza umana, non riducendosi a centri d’addestramento per competenze effimere.
Ciò richiederà alcune rivalutazioni e reintegrazioni del patrimonio umano in un contesto globale di educazione, e uno sforzo concertato per rompere le barriere disciplinari e le strutture dipartimentali che bloccano le nostre capacità dal formulare le grandi idee che il Genere Umano necessita.
Una idea di questo tipo che recentemente è emersa nel regno delle relazioni internazionali è il Dialogo delle Civiltà.
Politicamente, dal Trattato di Westfalia, le nazioni sono esistite come contenitori separati, nonostante i loro contenuti culturali, linguistici, religiosi e di altro tipo spesso fuoriuscissero. E’ chiaro adesso che nel mondo attuale dovremmo concentrarci più sulle fuoriuscite che sui contenitori.
Ciò richiederà nuove forme di comprensione culturale e di apprendimento. Come risultato, il progetto di dialogo delle civiltà è stato formulato dal filosofo austriaco Hans Koechler e successivamente promosso da molto leader mondiali e adottato alla 59esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005.
Dalla prospettiva dello sviluppo della noosfera, il dialogo fra civiltà conduce ad una possibilità di unificazione delle diverse comunità nel perseguimento di comuni obiettivi globali.
Infine, un’altra importante componente dello sviluppo della Noosfera è il ripensamento della funzione dei mercati nell’istruzione.
L’inizio del 21esimo secolo è caratterizzato da crescenti tentativi di privatizzazione di beni tradizionalmente pubblici, come l’istruzione. E’ ormai un luogo comune il considerare l’istruzione semplicemente un bene di mercato come altri.
In quest’ottica, gli accademici commerciano la loro eredità illuminista, promuovendosi come guardiani e creatori di sapere prodotto per il bene superiore dell’umanità. Essi promuovono il libero scambio di idee in una società democratica e dichiarano di lavorare per proteggere la libertà di pensiero, inclusa quella di dissentire dall’ortodossia prevalente. Ma, da una prospettiva neo-liberale, è difficile vedere una diretta correlazione fra i benefici dell’istruzione e quelli del mercato perché quattro anni di università formano un individuo con un sapere molto maggiore di quello richiesto per un lavoro. In termini di mercato ciò è stato criticato in quanto “spreco”, ma non lo è affatto – è potenziale inutilizzato.
Noi dovremo trasformare questo potenziale inutilizzato in qualcosa di più socialmente dinamico. Il sapere così acquisito, ma non utilizzato nel luogo di lavoro, deve ottenere uno sbocco creativo, così da diventare risorsa di nuove brecce scientifiche e culturali.
Attualmente, quando gli studenti lasciano l’università per ingrossare le fila dei lavoratori, tendono a considerare questo primo periodo come separato dal resto della loro vita. Invece di lasciare che la loro creatività produttiva venga dissipata nella vita adulta, dobbiamo trovare uno sbocco per la sua collocazione più naturale e recettiva, dove lo sprazzo della loro curiosità intellettuale era inizialmente acceso, nella madre delle loro anime: la loro alma mater.
Paradossalmente, mentre i mercati riducono l’offerta universitaria a quei soli corsi di studio che “fanno profitto” (cit.) e solo le competenze lì conferite sono “pratiche” (cit.), essi finiscono per ridurre la complessità intellettuale e impediscono all’Università di servire come luogo di sviluppo per soluzioni creative a problemi sociali.
In conclusione, la crisi globale attuale richiede un approccio radicalmente nuovo al sapere e una concezione radicalmente diversa dell’Università.
Per salvare l’unicità e la complessità della natura, abbiamo bisogno di saperne di più del Mondo nella sua totalità – decisamente agli antipodi rispetto all’approccio attuale su contenitori intellettuali altamente specializzati e segregati. Come accademico, Yulii Khariton, (4) uno dei fondatori del programma di energia atomica sovietico, dichiara: “Dovremmo conoscere dieci volte di più e solo dopo agire”.
Forse il rappresentarsi un simile compito come una missione di soccorso globale, una nuova e pratica Scienza di Preservazione Umana potrebbe infine rimpiazzare la superata e finanche autodistruttiva Scienza Prometeica dell’Illuminismo.
Una simile Scienza di Preservazione Umana potrebbe formulare la visione di una tensione umana non centrata sulle singole funzioni – economica, artistica, intellettuale – ma che abbia invece al centro l’armonia e l’equilibrio fra le componenti dell’esistenza umana. Dovrebbe servire come base per un “dialogo” attivo delle scienze naturali, umane e sociali, fornendo nuove visioni del mondo per la creazione della Noosfera.
Nell’antica Grecia, la parola “crisi” si riferisce alla rottura di legami.
Non è qualcosa da temere ma piuttosto da prevedere. Non tutte le generazioni ricevono simile opportunità. La scarsa lungimiranza è stato un male comune del genere umano in tutte le epoche ma, a causa della tecnologia e della globalizzazione, essa non è mai stata così pericolosa. Credo che l’Università dovrebbe abbracciare la sua vocazione storica e diventare ancora una volta il punto focale per la costruzione di una nuova ontologia, che superi le barriere disciplinari: superare le costrizioni intellettuali del paradigma neo-liberale e l’egocentrismo tipico del razionalismo post-illuminista.
Forse, come incubatrice di una Nuova Antropologia Salvifica Globale essa ci insegnerà come controllare gli strumenti sviluppati dalla scienza per il bene comune. Lo sviluppo sociale comune è in continua espansione e l’intero Universo è lo spazio per la sua implementazione.
Molte grazie per la vostra attenzione.
1) Come sappiamo grazie agli studi dell’autorevole professore canadese di pianificazione urbana William Rees (Università della British Columbia), per mantenere il livello di consumi dell’uomo medio occidentale sono richiesti dai quattro ai sei ettari di terra produttiva. E nel mondo le terre fertili possono soddisfare solo da 1,4 a 1,7 miliardi di persone. Ciò significa che qualcuno sta pagando per questo livello di consumi – altre nazioni o le prossime generazioni.
2) Oggi parliamo di nuove frontiere per gli sviluppi industriali e tecnologici, vertenti sul sapere economico, su tecnologie innovative ed efficienti. Tutte queste tematiche sono state già discusse e certi pratici obiettivi formulati. Cosa è successo a loro e in quale grado costituivano fantasmi ed utopie troppo lontane dalla realtà – è la domanda cruciale.
3) L’esistenza della vita sulla terra è vista come anti-entropica, come progresso della cultura umana verso maggiore ordine e complessità. Alcuni hanno persino teorizzato che il fine ultimo del Genere Umano in questo universo sia quello di invertire l’entropia, una nozione resa celebre nell’opera di Isaac Asimov “The Last Question” e in quella di Arthur C. Clarke “The 9 Billion Names of God”, entrambe considerate fra le dieci migliori opere di fantascienza di tutti i tempi.
4) Inventore della bomba termo-nucleare.
Traduzione di Giacomo Guarini